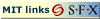Il saggio affronta, in un quadro di multilevel constitutionalism, le dinamiche istituzionali e giurisdizionali riguardanti le politiche comuni in tema di immigrazione e asilo che hanno trasfigurato, nell’arco di poco più di un ventennio, lo “spirito di Tampere” che aveva marcato il sorgere di uno “Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia”. Se infatti il Programma approvato nel 1999 dal Consiglio europeo di Tampere era stato il punto di approdo di un impegno degli Stati membri a realizzare, anche nel settore dell’immigrazione e dell’asilo, una integrazione europea fondata sulla “libertà”, connotata dai diritti fondamentali quali valori comuni e dotata di istituzioni democratiche operanti nel rispetto dello stato di diritto, le successive vicende hanno tracciato un percorso ben diverso, ben riflesse dalla torsione securitaria impressa allo Spazio LSG, da politiche europee “liquide” al di fuori dei Trattati europei segnate dal perverso connubio tra azione intergovernativa e informalità procedurale nel controllo delle frontiere, cui la stessa giurisprudenza del giudice europeo in materia di immigrazione ed asilo non ha saputo porre argine in ciò distinguendosi dal “cosmopolitismo” che connota la giurisprudenza di diverse corti costituzionali nazionali in tema di protezione del non cittadino, e tra queste segnatamente della Corte costituzionale italiana. Nel conflitto tra prerogative statali e diritti fondamentali in materia di immigrazione ed asilo, pur a fronte di pronunce garantiste, la Corte di Giustizia ha invece sposato un orientamento che, più che indice di judicial modesty tipicamente legata alla preoccupazione di preservare gli spazi del legislatore democratico, pare potersi più realisticamente inquadrare come espressione di denialism e passivism. Se dunque le vicende che hanno connotato sin qui le politiche migratorie dell’Unione, e segnatamente quelle che intersecano il diritto di asilo, destano da tempo allarme per lo stato della effettiva protezione dei diritti fondamentali dei migranti e richiedenti asilo, per invertire le tendenze in atto a livello sovranazionale – condizionanti gli ordinamenti nazionali non soltanto attraverso provvedimenti normativi, ma soprattutto attraverso prassi informali di soft law che comunque obbligano gli Stati sul piano della effettività – occorrerebbe coniugare esigenze di irrobustimento del political constitutionalism con nuove declinazioni del judicial constitutionalism nel segno di un intervento cooperativo delle corti costituzionali nazionali per orientare le politiche migratorie dell’Unione verso il pieno rispetto dei diritti fondamentali.
La lingua perduta di Tampere: frontiere e migranti tra sovranità degli Stati e diritti fondamentali
Tiberi G.
2021-01-01
Abstract
Il saggio affronta, in un quadro di multilevel constitutionalism, le dinamiche istituzionali e giurisdizionali riguardanti le politiche comuni in tema di immigrazione e asilo che hanno trasfigurato, nell’arco di poco più di un ventennio, lo “spirito di Tampere” che aveva marcato il sorgere di uno “Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia”. Se infatti il Programma approvato nel 1999 dal Consiglio europeo di Tampere era stato il punto di approdo di un impegno degli Stati membri a realizzare, anche nel settore dell’immigrazione e dell’asilo, una integrazione europea fondata sulla “libertà”, connotata dai diritti fondamentali quali valori comuni e dotata di istituzioni democratiche operanti nel rispetto dello stato di diritto, le successive vicende hanno tracciato un percorso ben diverso, ben riflesse dalla torsione securitaria impressa allo Spazio LSG, da politiche europee “liquide” al di fuori dei Trattati europei segnate dal perverso connubio tra azione intergovernativa e informalità procedurale nel controllo delle frontiere, cui la stessa giurisprudenza del giudice europeo in materia di immigrazione ed asilo non ha saputo porre argine in ciò distinguendosi dal “cosmopolitismo” che connota la giurisprudenza di diverse corti costituzionali nazionali in tema di protezione del non cittadino, e tra queste segnatamente della Corte costituzionale italiana. Nel conflitto tra prerogative statali e diritti fondamentali in materia di immigrazione ed asilo, pur a fronte di pronunce garantiste, la Corte di Giustizia ha invece sposato un orientamento che, più che indice di judicial modesty tipicamente legata alla preoccupazione di preservare gli spazi del legislatore democratico, pare potersi più realisticamente inquadrare come espressione di denialism e passivism. Se dunque le vicende che hanno connotato sin qui le politiche migratorie dell’Unione, e segnatamente quelle che intersecano il diritto di asilo, destano da tempo allarme per lo stato della effettiva protezione dei diritti fondamentali dei migranti e richiedenti asilo, per invertire le tendenze in atto a livello sovranazionale – condizionanti gli ordinamenti nazionali non soltanto attraverso provvedimenti normativi, ma soprattutto attraverso prassi informali di soft law che comunque obbligano gli Stati sul piano della effettività – occorrerebbe coniugare esigenze di irrobustimento del political constitutionalism con nuove declinazioni del judicial constitutionalism nel segno di un intervento cooperativo delle corti costituzionali nazionali per orientare le politiche migratorie dell’Unione verso il pieno rispetto dei diritti fondamentali.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Tiberi_LaLinguaPerdutadiTampere_EuropaTreDisincanti_2021.pdf
non disponibili
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Licenza:
Copyright dell'editore
Dimensione
647.52 kB
Formato
Adobe PDF
|
647.52 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.